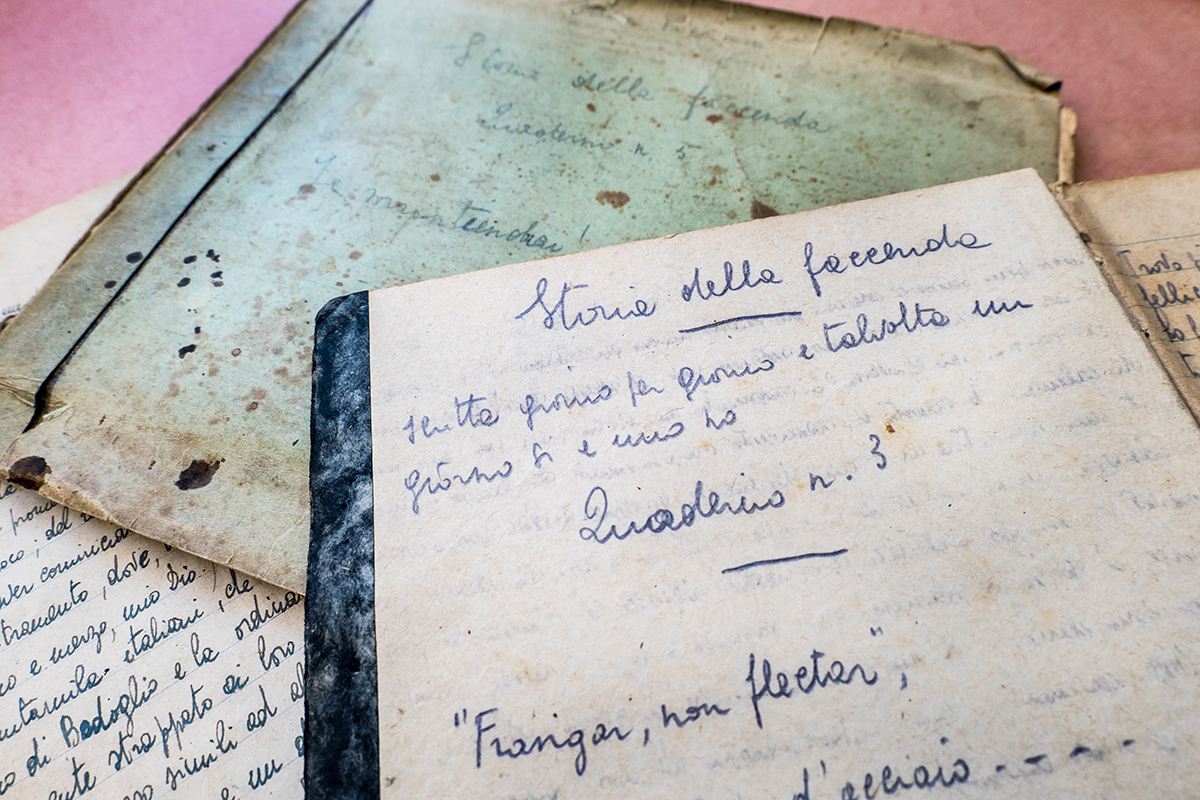Per un nativo o quasi nativo fascista, rompere lo schema, ammettere la responsabilità del regime, riconoscere l’orrore della guerra, è già un’impresa, come ribaltare in venti mesi vent’anni: i soldati del regio esercito, a eccezione di una minoranza che ha seguito gli ufficiali del No in un percorso di resistenza, sono stati risucchiati nella quotidiana sopravvivenza al durissimo lavoro per il Reich, costretti a trascorrere quei venti mesi in assoluto dominio dei nazisti, in una forma di deumanizzazione, che accentua la condizione di vittime. In conclusione, dovrebbe ora essere chiaro al lettore ciò che rende prezioso il diario di Piccinini. Non solo la facilità e la felicità della scrittura, non solo il fatto che le testimonianze di sottufficiali e soldati sono incomparabilmente di meno rispetto a quelle degli ufficiali, perché il più o meno duro lavoro coatto mal si conciliava con la scrittura quotidiana, ma soprattutto il fatto che il percorso di Piccinini, la sua presa di coscienza a metà, sofferta e parziale, rispetto alla “fiamma ideale” che ha riscaldato la prigionia di tanti ufficiali, è secondo me emblematica, e vorrei dire paradigmatica, di una larga maggioranza di internati, alcune centinaia di migliaia di soldati e sottufficiali giovani e giovanissimi, fascisti per educazione e formazione, che la sconfitta costringe a prendere atto del fallimento di ciò in cui credevano. Figli della seconda guerra mondiale, hanno rifiutato di combattere per una bandiera che non era la loro: nella ineludibile sottomissione alla schiavitù del lavoro hanno subìto e riflettuto, trepidato e tremato per la sorte dei loro cari e della patria lontana, iniziato un percorso complesso e sofferto di emancipazione dal loro passato.
dall’introduzione di Luciano Zani